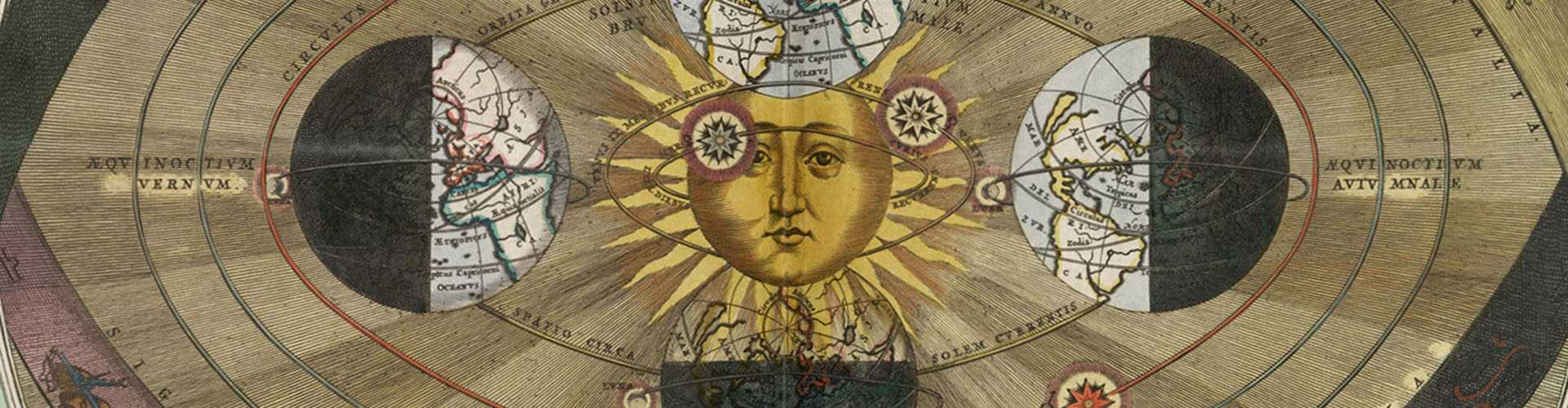Introduzione
Un vero e proprio scontro tra teologia e autonomia della scienza portò Galileo ad esporre le proprie ragioni in alcune lettere indirizzate a personalità a vario titolo coinvolte, che vanno sotto il nome di Lettere copernicane.
Il domenicano fiorentino Niccolò Lorini - predicatore generale dell'Ordine, nonché lettore di Storia ecclesiastica presso lo Studio di Firenze - il giorno dei morti del 1612 aveva duramente attaccato le tesi copernicane, come veniamo a sapere da una lettera inviata allo stesso Galileo, nell'intento di minimizzare la propria sortita.
Il Lorini denunciava apertamente la presunta inconciliabilità tra le tesi eliocentriche e il testo della Sacra Scrittura, e prendeva accanitamente posizione contro Galileo, che vedeva così aprirsi un nuovo fronte nella polemica, cui si troverà costretto negli anni a venire a replicare articolatamente (seppure, in definitiva, con scarso successo), lanciandosi in un ambito che esulava alquanto dal terreno strettamente scientifico.
La Lettera a Benedetto Castelli
L'opportunità di dire la propria in merito ai rapporti tra teoria eliocentrica e testo biblico venne offerta a Galileo da un episodio che vide protagonista il suo discepolo Benedetto Castelli, a quel tempo professore di matematica presso lo Studio di Pisa. Il 14 dicembre 1613 Castelli scrisse a Galileo di aver partecipato due giorni prima ad un pranzo granducale, presenti Cosimo II, la moglie Maria Maddalena d'Austria, la granduchessa madre Cristina di Lorena, Antonio de' Medici, Giovanni Paolo Orsini e Cosimo Boscaglia, filosofo dello Studio di Pisa. A tavola la granduchessa lo aveva interrogato sul moto della Terra e sulla sue dissonanze con le Sacre Scritture.
Appena sette giorni dopo, il 21 dicembre 1613, Galileo si rivolgeva al discepolo in forma epistolare, sviscerando il problema dell'accordo tra copernicanesimo e testi sacri, ed esprimendosi più in generale sul significato ed il valore dei contenuti scritturali in ambito scientifico. La Lettera a Benedetto Castelli [V, 281-288] contiene i capisaldi delle posizioni esegetiche che Galileo avrebbe in seguito dettagliato ed articolato nella celebre Lettera a Cristina di Lorena (1615), e ne anticipa i contenuti essenziali. Nonostante in via di principio la Scrittura non possa errare, possono però sbagliare i suoi interpreti nell'intenderne il significato genuino [V, 282]. Per quanto poi la Sacra Scrittura e la natura scaturiscano entrambe dal «Verbo divino», la prima deve adattarsi alle capacità di comprensione della gente comune, mentre la seconda segue inesorabilmente le sue proprie leggi: linguaggio biblico e linguaggio naturale sono nettamente distinti e tesi a due diverse finalità [V, 282]. Le acquisizioni scientifiche non possono perciò venire invalidate dal ricorso a passi scritturali che paiono giungere a conclusioni contrastanti [V, 283]. L'astronomia e le altre scienze della natura, delle quali pochissimo si parla nella Bibbia, vanno indagate dunque in modo autonomo: Dio ci ha dato infatti la possibilità di intendere il suo Verbo fatto natura attraverso i sensi e la ragione [V, 284].
Galileo entra poi nel merito del passo biblico invocato da Cristina di Lorena contro Copernico nel corso della discussione col Castelli. Si tratta del miracolo narrato in Giosuè, 10, 11-13, in cui Dio ferma il Sole al fine di prolungare il giorno e favorire così la vittoria degli Israeliti sugli Amorrei. Interpretandoli in modo strettamente letterale, quei versetti trovano rispondenza più nelle tesi copernicane che nella dottrina tolemaica [V, 285 e ss.].
Le reazioni alla Lettera a Benedetto Castelli
La Lettera a Benedetto Castelli non ha le caratteristiche di un documento privato, ma di un vero e proprio trattato, seppur breve, cui Galileo affidava le proprie riflessioni riguardo al rapporto tra conoscenza scientifica e rivelazione scritturale. Il testo circolò e si diffuse manoscritto, suscitando interesse non solo tra gli amici e i sostenitori, ma anche tra i rivali. Disgraziatamente non mancò chi vi trovasse appigli per inasprire la campagna antigalileiana che di lì a poco infuriò.
Ad un anno esatto dalla data di stesura della Lettera al Castelli, il 21 dicembre 1614, quarta domenica d'Avvento, Tommaso Caccini, un frate domenicano fiorentino, proferì dal pulpito di Santa Maria Novella parole di fuoco contro i "galileisti", e più in generale contro i matematici, additandoli come nemici della religione. Caccini - che secondo un tardo resoconto settecentesco avrebbe schernito nella sua predica le scoperte di Galileo con un gioco di parole basato sulla citazione di un passo del primo libro degli Atti degli Apostoli: «Viri Galilaei quid statis aspiciendum in caelum?» - prendeva spunto dal commento al decimo capitolo del libro di Giosuè (lo stesso contenente il famoso passo sul moto solare interpretato da Galileo in senso filocopernicano) per far apparire lo studio delle scienze matematiche una pratica sostanzialmente irreligiosa.
Non molto tempo dopo, il 7 febbraio 1615, il padre Niccolò Lorini, rimasto in ombra per quasi due anni e mezzo, si rifece vivo, denunciando Galileo con una lettera inviata a nome dei Padri di San Marco al cardinale Paolo Camillo Sfrondati, Prefetto della Congregazione dell'Indice. In verità nel documento non lo si menzionava mai per nome, ma si parlava solo di «galileisti», segnalando come «sospette o temerarie» le opinioni sui rapporti tra scienza e testi sacri consegnate alla Lettera al Castelli, della quale accludeva la «vera copia», divergente in alcuni punti cruciali da tutte le altre fatteci pervenire dalla tradizione, e quindi con tutta probabilità manipolata ad arte.
Le lettere a Piero Dini
Galileo nel frattempo - forse allo scopo di rettificare le espressioni non del tutto ortodosse della copia inviata a Roma dal Lorini - provvedeva a mettere in circolazione una nuova versione della Lettera al Castelli e il 16 febbraio 1615, affacciando il sospetto che il testo consegnato al Sant'Uffizio fosse stato falsificato, ne inviava a Piero Dini un esemplare corretto, chiedendo che fosse fatto leggere al padre Grienberger, matematico del Collegio Romano, e al cardinale Bellarmino [V, 292].
A questa lettera ne seguì un'altra datata 23 marzo. In entrambe [V, 291-305] Galileo chiariva ulteriormente le proprie idee sul rapporto tra astronomia copernicana ed esegesi biblica [V, 297], e particolarmente nella seconda - dopo aver energicamente rivendicato l'effettiva e reale esistenza in natura delle conclusioni de systemate mundi di Copernico, che non erano solo un espediente per "salvare i fenomeni", ma erano lo schema matematico della «vera disposizione delle parti del mondo» [V, 298] - si avventurava in una spiegazione dettagliata di alcuni passi biblici comunemente considerati avversi alla teoria eliocentrica, soffermandosi soprattutto sul Salmo 18, in cui si paragona il Sole ad un gigante che percorre il cielo da un estremo all'altro [V, 301]. L'intento era sempre quello di dimostrare che il presunto accordo tra alcuni luoghi scritturali e le tesi tolemaiche non poteva affatto dirsi scontato, poiché altre interpretazioni inclini verso la posizione copernicana apparivano ugualmente, quando non maggiormente, plausibili. La scelta di insistere sulla questione esegetica presentava non pochi rischi per Galileo, perché - come era stato avvertito da più parti - i teologi riconoscevano solo a se stessi, e senza deroghe, la prerogativa di interpreti accreditati delle Scritture.
La Lettera a Cristina di Lorena
Nonostante fosse stato consigliato più volte di non addentrarsi in questi argomenti, Galileo non mostrava alcuna intenzione di attestarsi sulle posizioni indicate dal cardinale Bellarmino nella lettera del 12 aprile 1615 indirizzata a Paolo Antonio Foscarini, autore della Lettera sopra l’opinione de’ Pittagorici e del Copernico della mobilità della Terra e stabilità del Sole, e del nuovo pittagorico sistema del mondo (Napoli, 1615): il copernicanesimo non poteva essere accettato come verità filosofica, ma soltanto come ipotesi matematica, altrimenti si sarebbe rischiato di condannare la Sacra Scrittura alla falsificazione, oltre a indurre all’ira i teologi delle scuole. Sicuro non solo della fondatezza delle proprie convinzioni cosmologiche, ma anche della persuasività dei propri argomenti a favore della conciliabilità fra tesi eliocentriche e testo biblico, Galileo rimaneggiò la Lettera a Benedetto Castelli indirizzandone una versione fedele nei contenuti, ma assai più ampia ed articolata, alla Granduchessa madre di Toscana, Cristina di Lorena.
Nella Lettera a Cristina di Lorena [V, 309-348], in aggiunta ai passi già elencati a sostegno delle proprie tesi [ad esempio V, 317 o V, 346], Galileo allarga il campo per rispondere a quanto scaturito dal dibattito successivo alla Lettera a Benedetto Castelli, soffermandosi in particolare sui rilievi emersi nella polemica fra Roberto Bellarmino e Paolo Antonio Foscarini. Galileo, comunque, accusa apertamente i suoi detrattori di aver montato ad arte, «col manto di simulata religione», il problema dell’incompatibilità fra teorie copernicane e Sacra Scrittura, nel tentativo «di fare scudo alle fallacie de’ lor discorsi» in difesa della tradizione cosmologica aristotelico-tolemaica. Hanno urlato perfino dai pulpiti contro il copernicanesimo, preconizzandone un’imminente condanna per eresia, «con poco pietoso e men considerato aggravio non solo di questa dottrina e di chi la segue, ma di tutte le matematiche e de’ matematici insieme» [V, 311].
La Scrittura, è vero, non può errare, ma bisogna comprenderne il senso genuino, che non si può «negare esser molte volte recondito e molto diverso da quello che suona il puro significato delle parole». Fermarsi al significato letterale è perciò fonte di errore, contraddizione, se non in certi casi di eresia, perché quelle parole «furono in tal guisa profferite da gli scrittori sacri per accomodarsi alla capacità del vulgo assai rozo e indisciplinato», in particolare riguardo alle questioni di filosofia naturale, le più difficili in assoluto ad essere capite. La natura, «osservantissima essecutrice de gli ordini di Dio» e la Scrittura Sacra, «dettatura dello Spirito Santo», procedono «di pari» dal Verbo divino. La natura, però, «inesorabile ed immutabile, e mai non trascendente i termini delle leggi impostegli, come quella che nulla cura che le sue recondite ragioni e modi d’operare sieno o non sieno esposti alla capacità degli uomini», non può essere altrimenti compresa se non attraverso sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, che non devono esser falsificate da contraddizioni apparenti nel testo biblico, dovute soltanto all’imperizia scientifica degli interpreti [V, 314-317].
Anche qui Galileo continua, con estrema decisione e in linea con le lettere precedenti, a rivendicare l’indipendenza dell’indagine naturalistica da ogni ingerenza dell’autorità teologica, che ha giurisdizione in materia di fede, ma non in materia di scienza: «io… direi quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado, ciò è l’intenzione dello Spirito Santo essere d’insegnarci come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo» [V, 319].
A parte lo stile epistolare, la lettera è di fatto un trattato vero e proprio, con tanto di riferimenti alle autorità teologiche (in primo luogo S. Agostino), invocate a difesa di nuove interpretazioni e in grado di sostenere la congruenza tra dettato scritturale e cosmologia copernicana. Galileo rivendica inoltre la libertà nell’indagine naturale, negando di esser giunti alla completa conoscenza della realtà. («E chi vuol por termine alli umani ingegni? Chi vorrà asserire già essersi veduto e saputo tutto quello che è al mondo di sensibile e di scibile?»). La conoscenza della natura, basata sul mettere continuamente in dubbio le conclusioni raggiunte, è desiderio connaturato all’uomo, e porle limiti equivale ad impedirne il progresso:
non si dovrà… precluder la strada al libero filosofare circa le cose del mondo e della natura, quasi che elleno sien di già state con certezza ritrovate e palesate tutte. Né si dovrebbe stimar temerità il non si quietare nelle opinioni già state quasi comuni, né dovrebb’esser chi prendesse a sdegno se alcuno non aderisce in dispute naturali a quell’opinione che piace loro, e massime intorno a problemi stati già migliaia d’anni controversi tra filosofi grandissimi, quale è la stabilità del Sole e mobilità della Terra [V, 320-321].
Non sarà sufficiente «serrar la bocca ad un solo» per eliminare il copernicanesimo dalla faccia della Terra e neppure proibire il libro di Copernico e gli scritti dei suoi seguaci. «Bisognerebbe interdire tutta la scienza d’astronomia intiera, e più vietar a gli uomini guardar verso il cielo», perché il progresso della conoscenza va avanti autonomamente, con buona pace di chi lo voglia ostacolare [V, 328]. Senza alcuna malizia, ma con una punta d’ingenuità, nel far rilevare l’illogicità di un atteggiamento censorio Galileo centrava inconsapevolmente il nodo storico del repentino accanimento contro il De revolutionibus di Copernico dopo più di settant’anni dalla sua pubblicazione.
Ma il proibire il Copernico, ora che per molte nuove osservazioni e per l’applicazione di molti literati alla sua lettura si va di giorno in giorno scoprendo più vera la sua posizione e ferma la sua dottrina, avendol’ammesso per tanti anni mentre egli era men seguito e confermato, parrebbe, a mio giudizio, un contravvenire alla verità, e cercar tanto più di occultarla e supprimerla, quanto più ella si dimostra palese e chiara [V, 328-329].
Annunciata già nel febbraio 1615 e quasi terminata alla metà di maggio, la Lettera a Cristina di Lorena fu con ogni probabilità definitivamente completata nel giugno del 1615. In questo periodo Galileo aveva già avuto notizia della minacciosa deposizione di Tommaso Caccini, il che contribuì forse a convincerlo dell’opportunità di non pubblicarla, affidandone la trasmissione delle proprie idee ad un’accorta diffusione di copie manoscritte.